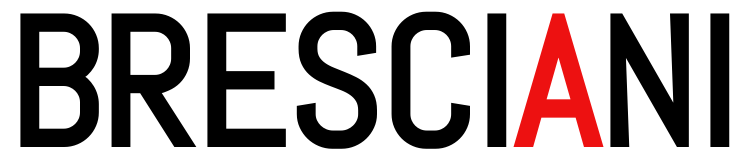CRISTINA MUCCIOLI
LA CERTEZZA MANSUETA DELL’ORDINARIO...


L’evento dell’opera d’arte trasforma lo stesso nell’inedito. E così, il tappeto di cenere di Narciso Bresciani, è il mai visto del tappeto, la forma mai assunta dalla cenere, il non ancora incontrato della quotidianità dimessa e mite, comune e sobria di entrambi gli elementi.
L’arte fa sempre irruzione, anche senza clamore, senza alcun rumore né ostentazione, poiché nel momento in cui si manifesta disarticola la grammatica del reale, il modo usuale con cui noi lo leggiamo riducendo qualsiasi oggetto alla sua funzione. Un tappeto serve per arredare, per attutire la durezza dei passi, per facilitare i primi che fanno gli infanti, per impreziosire un ambiente.
La cenere non serve più a niente, ma ci si lavava i panni per igienizzarli, e ci si concimava i campi. No no, niente di tutto questo ci permetterebbe anche soltanto di avvicinarci alla combinazione di tappeto e di cenere nell’opera di Bresciani, che trasfigura e leva ogni accomodamento di significato dal mondo pensato, accomodato, utilizzato, consumato, appaesato, convenzionale.
L’arte spaesa, coglie impreparati, innova il più liso, il più risaputo degli elementi e il più neutrale degli scopi.
L’opera d’arte non rappresenta, non si limita cioè a presentare una seconda volta la stessa cosa in immagine, ma presenta, mette in scena, sovverte, innesca, dissesta il senso comune, sposta i pensieri con la forza del non prevedibile, dell’imprevisto.
LA CERTEZZA MANSUETA DELL’ORDINARIO APRE UN VARCO AL POSSIBILE, IL QUALE SI DECLINA IN INFINITI MODI, QUANTE SONO LE SENSIBILITÀ, LE RISONANZE INTERIORI, LE ASSOCIAZIONI, I RICORDI, LE ASSONANZE SIMBOLICHE.
Bresciani convoca il pubblico non come semplice fruitore dell’opera, ma come coautore, perché ognuno sulla superficie della cenere può tracciare un segno, il proprio. Non ci si può camminare – questo prevederebbe un tappeto – perché la volatilità della cenere lo dissolverebbe. Questo implica che nessuno potrà stare al centro, ma solo ai margini, come si fa a tavola, con riguardo e convivialità.
Si può, invece, ritrovare la sorgività del gesto tattile che lascia impronta, che significa con le dita, con le mani, con un bastoncino come loro protesi. Non sarà un per sempre, perché il supporto non conserva, bensì fa apparire, svela qualcosa che prima era sigillato e nascosto dentro di noi, rende visibile l’invisibile (ricordando grati l’insegnamento di Paul Klee) che siamo quando pensiamo e immaginiamo. Anche la transitorietà di questo fare è delicatamente ma decisivamente insubordinato. Siamo soliti pensare all’opra ‘monumento’, una crasi da ‘memento’ che è l’imperativo latino corrispondente all’esortazione al ricordo, a ciò che sta e sa restare incorrotto, immobile, inalterato.
La cenere è volatile, leggerissima, inadatta e incapace di trattenere a lungo, ma accogliente nella ricezione di un gesto significante, che insieme ad altri diventa coralità silente, discorso, colloquio. Non occorre forza, talento espressivo, ma fiducia. Serve fidarsi dell’ambiente e degli altri presenti per tracciare un solco poco profondo, eppure visibile, su un manto leggero e friabilissimo come un tappeto di cenere. E implica il piegarsi, il chinarsi e l’inchinarsi all’opera per farne attivamente parte.
Di nuovo, un’alterazione nell’abitudine di frequentare le opere, generalmente incorniciate e appese a una parete, oppure allestite su un piedistallo che, alto o basso, ci mantiene retti, eretti e corretti, tutti d’un pezzo, senza pieghe, senza ‘plica’. La vita, però, è drammaticamente com-plicata, piegata già da una nascita che include e prevede il nostro essere mortali, il nostro essere allo stesso tempo unici, irripetibili, mai esistiti prima, ma assegnati al divenire, alla transitorietà, alla fine. Eppure, possiamo sentirci tappeto di cenere non tanto perché noi stessi, come ammoniscono i testi sacri, torneremo ad esserlo, ma perché la cenere qui, nell’opera di Bresciani, ha una forma geometrica 1perfettamente definita: il rettangolo. Tale forma è un atto di resistenza contro la dissoluzione e l’informe. I nostri stessi gesti scrittorii (non alludendo naturalmente alla sola scrittura alfabetica) sono inscritti in quella forma, in quella pagina posata a terra, in quell’estensione di materia delimitata da un contorno netto, anche nel senso di pulito. Il caos, il soggettivo, l’imprevedibile è arginato all’interno. Se ‘andare in cenere’ rinvia alla dissoluzione, qui non si va ma si viene alla cenere per esistere e per consistere insieme con gli altri in un arazzo di segni che sono, sinteticamente, la nostra cultura. Cultura, da colere, coltivare, ha richiesto sin da subito il nostro chinarci alla terra, che abbiamo considerata sacra prima di aggredirla intensivamente, predatoriamente
Quest’opera ha il suo avvenire nel nostro esserci e partecipare, nella memoria del nostro gesto, di quella postura che solo il raccogliere qualcosa da terra oramai ci appartiene. In questo caso, invece di raccogliere depositiamo qualcosa per lasciarlo poi svanire, come quando i bambini disegnano sui vetri appannati o sulla sabbia, sulla neve, senza esibizionismo, senza teatralità. La cenere si produce dall’ustione. A bruciare, in quest’opera, è stata la legna. Theodor Adorno nella sua Teoria estetica definisce l’opera d’arte come luogo di resistenza, la quale non può essere certo ridotta a mera provocazione o al sensazionalismo da collezione di like, per attualizzare. La cenere che si fa opera è l’emblema della resistenza alla nientificazione, dell’ulteriorità alla corrosione della materia. Traccia residua di calore, di luce, di cottura del cibo, la cenere di questo tappeto è un grazie senza voce, una preghiera laica recitata non prima, ma dopo aver mangiato, dopo che ci si è scaldati, dopo aver illuminato. Forse, anche dopo esserci bruciati.
Né calda né fredda, né liquida né compatta, la cenere è il lasciato dalla pretesa di annientamento, è la prova di un’ustione, di un incendio, di una distruzione ineluttabile, che viene però ricondotta entro un perimetro, all’interno di una sala museale (alla Fabbrica del Vapore a Milano), per farsi occasione di forma, di relazione, di meditazione.
Il suo stesso colore, il grigio, rinvia nella sua pacatezza antiesuberante al silenzio. Il silenzio è condizione essenziale perché l’opera possa darsi ed essere vissuta, anche quando è
musicale. Si è in ascolto quando si tace, e si fa spazio all’altro. Il grigio sembra assorbire, e poi restituirlo. Umilissimo, il grigio è l’unico colore, come insegnava Bruno Munari, che lascia emergere anche il bianco.
È il colore dell’ombra che testimonia dell’esistenza dei corpi, e della resistenza al loro completo annullamento, all’oblio. È il colore di ciò che non si è lasciato distruggere dal fuoco.
Cristina Muccioli
Critico d’arte, Docente di Etica della Comunicazione e di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Brera